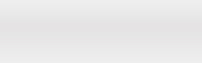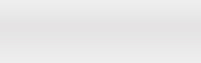Le Fagacee: indagine palinologica nella città di Faenza
O. Quercia, F. Emiliani, F.G. Stefanini Ambulatorio di Allergologia - Dipartimento di Medicina Ospedale di Faenza (RA)
Introduzione
I pollini sono le cellule riproduttive maschili delle piante superiori, molte delle quali ne affidano al vento il trasporto fino al fiore femminile e, nel periodo della fioritura, quando la quantità del polline è elevata, alcune specie possono essere responsabili di fastidiose e a volte gravi manifestazioni allergiche. E’ nell’ambito dell’aerobiologia, disciplina che si occupa della provenienza, del rilascio, del trasporto in atmosfera, della deposizione e impatto sui diversi substrati di particelle allergeniche, che si inserisce il monitoraggio di pollini, che permette la stesura di un calendario pollinico tipico di una determinata zona geografica e del suo ambiente climatico. Gli andamenti pollinici sono infatti valutati in relazione alla situazione meteoclimatica locale e più precisamente in relazione al numero di giorni con precipitazioni di 1 mm almeno, poiché è possibile osservare l’esistenza di un parallelismo tra curva pollinica e temperatura ed un andamento del tutto opposto con piovosita’ e temperatura relativa (V min di pioggia ÞV max di concentrazione pollinica). La conoscenza dei periodi di comparsa nell’aria di aereoallergeni è sicuramente di interesse per l’allergologo (sia dal punto di vista diagnostico sia terapeutico), ma anche per l’allergopatico, che può così interpretare correttamente i propri sintomi ed eventualmente scegliere misure profilattiche, come allontanarsi da zone con alta concentrazione di pollini a lui nocivi a favore di zone in cui la concentrazione sia più bassa.

Le Fagacee
La famiglia delle Fagaceae riunisce unicamente piante legnose, distribuite nelle regioni temperate dell'Eurasia e delle Americhe con i generi Castanea, Quercus, Fagus e Nothofagus. Si tratta di una famiglia piuttosto primitiva che riunisce alcuni tra i principali alberi dei nostri boschi.
Il frutto è una noce provvista di una cupula, che può avvolgerla completamente (es. Castanea, Fagus) o solo nella parte apicale (es. Quercus).
L'impollinazione è per lo più anemogama, ma è entomogama in Castanea. L'importanza della famiglia risiede nella grande estensione e diffusione sulla terra di foreste, localizzate soprattutto nelle regioni temperate, in cui le fagacee sono le essenze dominanti.
Molte specie sono largamente utilizzate per produrre legno e cellulosa.
Fagus sylvatica - Faggio - Beech
Il Faggio (Fagus sylvatica) è una tipica latifoglia di montagna, alta fino a 30-40 metri, di tronco dritto e cilindrico, con una chioma prima conica, poi ampia e densa, più o meno tondeggiante. Cresce nella zona superiore a quella delle querce e del castagno, cioè tra i 900 e i 1600 metri, dove forma sia faggete pure sia boschi in associazione con l'abete bianco. Piuttosto adattabile, teme però i venti secchi e ha bisogno di precipitazioni abbondanti (almeno 1000 mm annui). Il tronco, tanto più sottile quanto più fitta è la faggeta, ha una corteccia liscia, cinerina, spesso con licheni. Le foglie sono ovoidali con evidenti nervature, verde chiaro in primavera, verde scuro in estate, giallo oro e rosso rame in autunno, prima di cadere. I fiori, non molto visibili, appaiono con le foglie in aprile-maggio: quelli maschili sono riuniti in amenti. I frutti sono avvolti da un involucro spinoso (derivato dalla protezione del fiore femminile) che si apre in quattro spicchi.
Ha un'ottima capacità pollonifera, e viene spesso allevato a ceduo per la produzione di carbone vegetale. Il legno serve anche ad affumicare prosciutti, salmoni, lingua ed aringhe, e ha poteri antisettici. Per distillazione del catrame del legno si ottiene il creosoto, un disinfettante delle vie respiratorie.
Castanea sativa - Castagno - Sweet chestnut
Il castagno, originario dell'Iran, diffuso in Europa artificialmente fin dall’antichità, è una specie che può facilmente acclimatarsi inogni regione del nostro continente, tranne nei terreni calcarei.
Se ne conoscono 17 specie nel solo emisfero settentrionale. La specie europea o castagno comune è un albero maestoso col fusto grosso, rivestito di corteccia di color grigio-bruno, screpolato. Può raggiungere i 30 metri di altezza e i 15 di circonferenza e vivere fino a 1000 anni.
Cresce in tutta Europa fino a 1000 metri sulle Alpi, fino a 1200 metri nella regione mediterranea. In Italia il castagno è diffusissimo, particolarmente in Toscana, Emilia Romagna, Calabria, Piemonte e Liguria.
Predilige suoli drenati e con poco calcio. Forma vasti boschi e viene coltivato dalla zona delle sclerofille sempreverdi mediterranea a quella delle quercie. L’impollinazione è anemofila.
Il polline è un granulo tricolporato, isopolare e prolato, l’esina con rugulatura poco marcata. Le dimensioni sono piuttosto piccole (11-16-micron)
Il periodo di fioritura nella nostra zona si colloca all’inizio di luglio.
Quercus ilex - Leccio - Oak
Il leccio è una specie mediterranea e si ritrova dalle coste dell’Europa all’Africa settentrionale, comprende circa 200 specie di cui 8 presenti in Italia. Può raggiungere i 25 m d’altezza con tronco eretto e robusto con diametro anche di un metro, la chioma è ovale e molto densa di colore verde scuro con corteccia nerastra rotta in piccole squame. Cresce bene su substrati calcarei.
Le foglie sono lanceolate, alterne, coriacee, di colore verde scuro, lucide nella pagina superiore e bianco cotonose su quella inferiore per la presenza di peli stellati con margine dentato o intero o spinoso.
I fiori maschili sono raccolti in amenti penduli con stami gialli, mentre i femminili possono essere anche solitari.
I frutti sono ghiande ovoidali protetti da una cupola emisferica squamosa.
Il polline è un granulo isopolare, tricolpato e e in visione polare ha profilo subtriangolare con solchi lungitudinali. L’esina è con superficie verrucata e spessa, l’intina è di spessore medio. Le dimensioni sono medie-piccole intorno a 25-27 micron.
L’impollinazione è anemofila e avviene in aprile-maggio.
Essendo un sempreverde ed adattandosi bene anche a basse altitudini, viene utilizzato come piante ornamentali in molti viali cittadini
Quercus cerris - Cerro - Turkey Oake
Qercus pubescens - Roverella - Downey Oak
Specie entrambe appartenenti alla famiglia delle Fagacee, con struttura pollinica simile a quella del Leccio (il Cerro ha pollini leggermente piu’ grandi); l’impollinazione e’ sempre anomofila e il periodo di fioritura si sovrappone a quella del Leccio.
Tutte le specie del genere Quercus hanno polline con le stesse qualita’ allergeniche in modo che qualsiasi grande quantita’ presente nell’aria puo’ causare pollinosi.
Analisi del territorio
Nella zona intorno a Faenza, collocata tra le vallate del fiume Lamone e quella del fiume Marzeno, assume una discreta importanza l’impollinazione delle Fagaceae.
Faenza sorge a circa 45 km dal mare Adriatico, a 36 m sul livello del mare, vicino alle colline dell’appennino tosco-romagnolo ed il suo entroterra è costituito da boscaglia di sempreverdi e di alberi con fogliame persistente o caducifoglie
Nella parte piu’ alta delle vallate in direzione sud - ovest (zona pre-appenninica a 600 - 700 m.s.l) sono presenti numerosi castagneti, che si estendono per una superficie di diverse centinaia di etteri.
Inoltre, da un censimento del verde pubblico eseguito nella nostra cittadina nel 2000 è emersa la presenza di numerosi alberi della famiglia delle fagacee, tra cui 837 della specie Quercus (in particolare 280 della specie Q. Ilex), 89 della specie Fagus Sylvatica e 3 della specie Castanea Sativa.
Abbiamo perciò voluto analizzare l’andamento del polline degli alberi appartenenti alla famiglia delle Fagacee (negli anni 1999 - 2000 - 2001) che nel nostro territorio, per i motivi sopra elencati, rappresentano una realtà tangibile.
Solitamente la carica pollinica maggiore nell’atmosfera si riscontra nel periodo tra febbraio e giugno. In questo periodo, infatti, si ha dapprima la pollinazione della maggior parte degli alberi, a cui fa seguito la stagione delle graminacee, della parietaria e dell’olivo.
Con l’inizio dell’estate la quantità di polline tende progressivamente a decrescere in quanto quasi tutte le piante hanno terminato la fioritura
Ogni stagione pollinica è poi anche influenzata dalla temperatura e dalla quantità di giornate di pioggia e di vento che determinano delle variazioni, anche piuttosto sensibili tra un anno e l’altro, della concentrazione per m3 di pollini.
Gli andamenti mensili del polline di fagacee vengono valutati in rapporto alla situazione meteoclimatica locale, poiché è nota l’esistenza di un parallelismo tra curva pollinica e temperatura ed un andamento del tutto opposto con piovosità e umidità relativa.
LECCIO e QUERCIA: i pollini compaiono solitamente fin dalla prima settimana di APRILE ed hanno un andamento crescente per tutto il mese, con concentrazioni sovrapponibili nel 2000 e 2001, come si può vedere dal grafico, con valori intorno ai 100 granuli/m3 alla fine del mese. Si differenzia invece il 1999 in quanto troviamo appena 25 granuli/ m3 e questo dato è correlabile con una situazione meteoclimatica sfavorevole.
Per quanto riguarda l’impollinazione nel mese di MAGGIO, ciò che si nota dall’analisi dei dati è la presenza di un basso valore del picco massimo del polline di Leccio e di Quercia raggiunto nell’anno 99 rispetto agli altri due anni. Infatti i valori nel 99 non superano i 35 pollini per m3, segnalando un ridotto aumento della concentrazione pollinica da aprile a maggio.
I valori negli altri anni sono invece sovrapponibili, con picchi pari a 638 pollini per m3 (2000) e 800 pollini per m3 (2001) nella seconda settimana del mese: in questo periodo le precipitazioni sono state di 0,6 mm, le temperature intorno ai 25 gradi e il vento fino a 34 km/s il giorno 11/05/2000, data che coincide con il picco massimo.
Il 1999, invece, con la presenza di numerose giornate di pioggia e un abbassamento della temperatura, è stato caratterizzato da un generale abbattimento della carica pollinica nell’atmosfera, dimostrata dal valore ridotto anche dei pollini che storicamente raggiungono picchi elevati in questo periodo (graminacee, urticacee nella varietà della parietaria).
Analogamente la brusca caduta dei pollini del giorno 07/05/2000 coincide con 28.2 mm di pioggia e T. max di 20,4 gradi che sono i valori peggiori di tutto il mese. Dati simili sono stati rilevati anche nel 2001 (7 e 16 luglio), anno in cui si segnala un allungamento del periodo pollinico con concentrazioni medio-alte fino alla fine del mese correlato alla temperatura elevata (25-32 C°), assenza di precipitazioni e vento a regime di brezza (25-35 km/s).
Nel mese di GIUGNO si assiste ad una graduale scomparsa del polline di queste specie, poiché le piante in questione hanno finito il loro periodo di fioritura
CASTAGNO: il polline di questa specie comincia a comparire fin dalla prima decade di GIUGNO e raggiunge concentrazioni significative intorno all’ultima settimana del mese. I valori nei tre anni considerati sono sovrapponibili: infatti il polline di questo albero risente delle condizioni meteoclimatiche precedenti al periodo dell’impollinazione che solitamente però sono piuttosto stabil,i come temperatura (30-34C°), precipitazioni (assenti), umidità e vento.
La presenza per la maggior parte dell’estate di libeccio, (vento proveniente da sud ovest) che nelle nostre zone trasporta i pollini delle zone collinari e pedemontani preapenniniche, e’ compatibile con il picco del polline di castagno (56 pollini per m3 nel 1999, 65 nel 2000 e 56 nel 2001), monitorati in alte concentrazioni dal nostro rilevatore, nonostante in citta’ siano presenti solo 3 esemplari di questo albero, oltretutto di giovane eta’ e quindi poco attivo dal punto di vista pollonifero.
Già verso la metà di luglio si assiste ad una netta riduzione delle concentrazioni di questo polline, in quanto il castagno ha terminato la sua fioritura.
Gli altri venti frequenti nella zona di Faenza (la tramontana proveniente da nord e il grecale da Nord-Est) assumono, per quanto riguarda il polline di castagno, scarsa importanza poiché provengono da zone pianeggianti dove questo tipo di albero non cresce.
Da questa breve analisi aerobiologica possiamo osservare, come segnalato e osservato in altre città europee, che anche i nostri dati sono l’espressione di un aumento complessivo delle concentrazioni di pollini/metro cubo delle Fagacee.
Per quanto riguarda la clinica, la correlazione tra una sintomatologia rinobronchiale e la presenza di positività allo SPT per questi alberi è abbastanza complessa, vista la frequente associazione con altre positività, soprattutto graminaceee e parietaria, il cui periodo di fioritura si sovrappone a quello delle fagacee
Vista comunque l’importanza ambientale di questa famiglia di alberi nella nostra realtà abitativa, ritenimo utile indagarli, soprattutto di fronte ad una discrepanza tra la sintomatologia primaverile - inizio estiva e le positività riscontrate a livello cutaneo per i comuni allergeni presenti in quel periodo.
Attualmente stiamo valutando. attraverso lo “score” dei sintomi e la positività dei test cutanei. una correlazione con gli alti valori pollinici al fine di identificare pazienti monosensibili ed inquadrare meglio la capacità allergizzante di un polline fino ad ora considerato scarsamente allergienico, anche se presente per lunghi periodi e a concentrazioni molto elevate con alcuni picchi pollinici a maggio-giugno (Leccio, Quercia) e a giugno-luglio (Castagno).